Tonino Dessì
L’omicidio del ragazzo di Orune e la scomparsa, si teme tragicamente collegata, di un altro ragazzo di Nule hanno riaperto una discussione non nuova sulla violenza nell’Isola, che il fatto della scorsa settimana sembra nuovamente, nei commenti mediatici, ricondurre e confinare in una specifica area geografico-culturale. È bene sempre tuttavia rifuggire da generalizzazioni di tipo antropologico, perché fatti salvi i casi di omicidi connessi alla presenza di criminalità organizzata, che ruotano su precisi interessi economici e che hanno una loro serialita’ e diffusione, i casi specifici, quali sono stati almeno negli ultimi trent’anni in Sardegna, hanno invece ciascuno una propria non ripetibile storia. Le indagini degli investigatori peraltro, in questa vicenda potrebbero riservare sorprese nemmeno immaginate. Certo e’ difficile sfuggire all’impulso di una valutazione di contesto, in occasione di un fatto che ci coinvolge emotivamente anche nella sfera privata, prima ancora che in quella pubblica. Non siamo in pochi a chiederci infatti: “Potrebbe succedere a mio figlio o a mia figlia?”.
Molti si interrogano, per esempio, sulla diffusione delle armi in Sardegna. In effetti, siamo obiettivi: la questione delle armi e della loro circolazione, legale e illegale, in Italia e’ ormai fuori controllo dappertutto. Semmai in Sardegna si nota meno, perché da noi omicidi come quello di Orune non sono una realtà quasi quotidiana come, che so, nell’area napoletana. La verità è non solo che di armi ce ne sono troppe, in giro, ma che il loro uso è totalmente disinibito, nel conscio e nell’inconscio, dall’assuefazione culturale mediaticamente amplificata e molecolarmente somministrata.
Ma veniamo al grosso della questione.
C’è’ da restare stupefatti di fronte alla povertà analitica che si rinviene oggi in troppi commenti di intellettuali e di accademici. Suona vuoto richiamarsi ad Antonio Pigliaru; ancorche’ nessuno lo abbia fatto, avrei trovato più giustificato, pur se ormai del tutto inutile per la comprensione dell’attualità, qualche riferimento a Gavino Ledda, il cui romanzo si collocava almeno nella transizione da una fase a un’altra della formazione familiare e individuale in una parte del mondo rurale sardo. Il fatto è che la condizione giovanile sarda non è indagata, nella sua “specificità”, da nessuno e da tempo immemore.
Qualcuno sa qual è l’ambiente giovanile specifico a Latte Dolce, Sassari, o a Piazza Medaglia Miracolosa, Cagliari o a “Su Nuraghe”, a Nuoro?
Il rapporto con la scolarità, con il non-lavoro, con i media e con i loro modelli, con i social e le loro modalità di comunicazione, con gli stupefacenti, col sottomondo illegale?
Ma poi, siamo certi che, nei quartieri “normali” delle città (ne esistono?), la condizione sia differente?
Le stesse domande andrebbero fatte in Barbagia (ma non esclusivamente: Nule, in Goceano, e’ a 15 chilometri) dove la specificità e’ meno circoscritta quanto a spazi ed evidente quanto ad appartenenze sociali rispetto ai grandi quartieri urbani, non solo popolari e subpopolari. Domande identiche, o al più con qualche variante.
Il rapporto con le ragazze, per citare un problema serissimo. Negli anni ‘80, per esempio, si osservava come l’accentuata evoluzione culturale femminile spiazzasse nei piccoli paesi, in particolare, una larga fascia di maschi di pari età, in difficoltà ad essere accettati come partner e indotti a ghettizzarsi in ambiti connotati da una strisciante e rancorosa misoginia e da un antagonismo latente verso coetanei più sintonizzati su quell’evoluzione.
Il tema dell’alcool, inoltre, il cui abuso e’ tuttora endemico. Quanto e come oggi caratterizza le forme della socialità giovanile?
E il sottomondo criminale, contiguo, tuttavia non esclusivamente coincidente con quello delle droghe, come si e’ capillarizzato nelle campagne semiabbandonate?
Insomma, le perduranti e inutili, in questo caso, fascinazioni etno-antropologiche dovrebbero essere superate, finalmente, dall’indagine e dalla riflessione “sul campo”.
Altrimenti non se ne cava piede e ciascuno di noi resta privo di spiegazioni plausibili non di un fatto nella sua singolarità, bensì di una dimensione intera, perciò in balia della diffidenza, della paura, dell’impotenza.


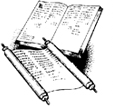

6 commenti
1 Vito Biolchini
16 Maggio 2015 - 09:51
I dati esistono, eccome se esistono. L’osservatorio sociale sulla criminalità in Sardegna, diretto dalla professoressa Mazzette dell’Università di Sassari, ha presentato sei mesi fa il quarto rapporto sulla criminalità in Sardegna, di cui si ritrovano in rete interessanti resoconti. Il primo rapporto risale al 2006 ed è consultabile a questo link.
http://eprints.uniss.it/4342/1/Mazzette_A_Libro_2006_Criminalità.pdf
2 Tonino Dessi'
16 Maggio 2015 - 13:54
A occhio risposte alle domande che pongo io non sembrerebbero essercene. Saranno sbagliate le mie domande, al solito.
Aggiungo, tuttavia, che le domande che pongo, per quanto Biolchini possa trovarle incongrue, riguardano la condizione giovanile in Sardegna e lo stato della sua conoscenza. Ricondurla alla “questione criminale”, soprattutto nel caso di cui si parla, comporta il rischio di un duplice errore: sovrapporre questione giovanile e questione criminale -mentre la seconda e’ semmai una realtà con cui giovani e famiglie si possono imbattere- e sovrapporre la questione delle aree interne della Sardegna ancora con la questione criminale fin quasi a farle coincidere. Operazione in effetti ricorrente, ma in ambienti culturali ai quali non ho mai appartenuto e ai quali non rischierei di fornire supporto nemmeno per inclinazione a evidenziare le peculiarità di un retaggio territoriale nel quale son nato e vissuto.
3 Vito Biolchini
17 Maggio 2015 - 07:52
Nessuno riconduce la questione giovanile alla questione criminale. Quello di Orune è però un omicidio (forse duplice) e come tale va principalmente trattato. Lo studio della Mazzette ci fornisce gli strumenti sociologici per farlo. Se invece la vicenda di Orune la si analizza prioritariamente come se fosse un semplice caso di disagio giovanile si compie secondo me un errore di metodo e non andiamo molto avanti nella comprensione della realtà. Partendo dagli studi della Mazzette (cinque rapporti sulla criminalità in Sardegna più altri lavori specifici) possiamo iniziare a capire invece in che contesto sociale avvengono questi fatti di sangue che purtroppo hanno in una precisa zona della Sardegna una ricorrenza maggiore che nel resto dell’isola. Ma di questa terribile verità molti sardi non vogliono farsi carico.
4 Tonino Dessi'
17 Maggio 2015 - 09:08
Come ha osservato Andrea in un suo precedente articolo, e’ una differenza di visione della “questione sarda” contemporanea non nuova. Anche con Antonietta e all’interno del Manifesto e del PdUP sardi se ne discusse per quasi un decennio, ma non con i toni ideologici che sorprendentemente oggi ritrovo in altri. Noi comunque eravamo più vicini alle tesi e alla diretta testimonianza dei compagni di Orgosolo e di Gavoi, ma nemmeno Antonietta allora ne’ oggi credo autorizzerebbe un uso “lombrosiano” del risultato dei suoi lavori. Non mi pare comunque che sia una differenza di punti di vista conciliabile ed è preferibile, almeno per quel che mi riguarda, lasciare ad altri che leggono il giudizio.
5 Vito Biolchini
17 Maggio 2015 - 10:28
Ma chi tira in ballo Lombroso? L’unico tono ideologico è quello di chi non vuole riconoscere che c’è una precisa area della Sardegna dove avvengono più omicidi, le cui caratteristiche sono tristemente ricorrenti. Paragonare i fatti di Orune con quelli di Milano è suggestivo ma non ha molto senso, se non altro perché nei fatti di Orune il fattore scatenante è il possesso di un’arma e il ruolo degli adulti è pari a quello dei giovani.
6 Tonino Dessi'
17 Maggio 2015 - 12:10
Ho usato l’espressione “uso lombrosiano” io, consapevolmente e sapendo che chi ha familiarità sui temi di questa discussione può capire.
Non ho equiparato, nemmeno provocatoriamente, Orune o Nule a Milano. Questo lo ha fatto Andrea e gli ho evidenziato un mio distinguo. Chiedo solo che non capiti ancora una volta di esser accomunato grossolanamente a posizioni con le quali ho molti punti di contatto ma anche elementi di riflessione personale e specifica. Me ne sono doluto altre volte senza esito, tuttavia una persistenza la troverei ingiustificabile. Infine, io ho posto delle domande. La modalità interrogativa e’ tipica di chi cerca risposte e non ha una tesi precostituita. Al momento, almeno in questa interlocuzione, risposte non ne ho trovato e nemmeno, a dire il vero, me ne stupisco.
Prima di chiudere, una cosa devo aggiungerla, perché l’altra prevedibile possibilità che troverei ingiustificata e’ il rischio che io voglia sminuire il lavoro pluridecennale di Antonietta e perché sia chiaro che anche professionalmente sono addestrato a valutazioni di dati complessi. La Provincia di Nuoro e al suo interno la Barbagia sono state tradizionalmente tra le aree caratterizzate, nella statistica giudiziaria, soprattutto del secolo scorso, dal più elevato tasso di contenziosita’ civile, prima ancora che penale. In questo storico ricorso alla giustizia pubblica emerge una realtà tutt’altro che prigioniera di stereotipi etnici. Che poi le risposte pubbliche a questa domanda di giustizia siano state anch’esse, come in altri campi della vita civile, inadeguate e frustranti dovrebbe essere una delle altre chiavi di lettura, non meno importante dell’indice di criminalità. Detto questo, oggi e’, alla fin fine, domenica.
Lascia un commento