Silvia Nicolai, costituzionalista nell’Univ. di Cagliari
da Il Manifesto del 15.5.2015
Secondo alcuni la Corte costituzionale, con la sentenza sulle pensioni, ha interferito nelle valutazioni politico-finanziarie riservate al legislatore e al governo; e, in nome di ormai ingiustificabili privilegi dei pensionati, ha sacrificato i diritti delle generazioni future, che il provvedimento annullato avrebbe inteso garantire. Mi pare invece che la Corte, in questo caso, si sia mantenuta nel suo, adottando l’approccio proprio di un giudice. Si è interrogata sul se vi siano stati o meno, da parte del legislatore, una corretta messa a fuoco e quindi un equo contemperamento della pluralità di beni e interessi che sono in gioco. Rilevato che ciò non è stato, ha rimesso agli organi politici il compito di ricomporre la propria valutazione tenendo presente la gamma più ampia di interessi, beni e principi, che essi hanno sottovalutato.Vediamo la questione, per come la Corte la ricostruisce. Il governo nel 2011 adotta un decreto che, appellandosi alla «contingente situazione finanziaria», interviene sulla perequazione delle pensioni di anzianità, discostandosi dai criteri fino ad allora seguiti, e dopo di allora di nuovo adottati, dalla legislazione in materia (anziché operare una rimodulazione della perequazione per fasce di reddito, il decreto sospendeva integralmente, per due anni, la perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo, colpendoli nel loro complesso). Anche nella vita di tutti i giorni, se qualcuno che ci ha sempre riservato un certo trattamento, improvvisamente cambia atteggiamento e ne adotta uno molto più duro nei nostri confronti, ci aspettiamo che ci offra valide ragioni, altrimenti lo giudichiamo arbitrario o ci chiediamo se davvero sa quello che fa. Ed è proprio dello stile della Corte ragionare similmente. Deviare da una tradizione legislativa già ritenuta costituzionalmente compatibile è sempre possibile, perché è ovvio che la legislazione fronteggi il mutamento, e anzi lo costruisca, ma richiede lo sforzo di salvaguardare la coerenza della nuova scelta con un quadro di principi che altrimenti non potrebbe rimanere valido, e condiviso. Si può intervenire sulla perequazione delle pensioni, dice la Corte, ma — e aveva già avvertito il governo in tal senso — non fino al punto di sacrificare la loro natura di retribuzione differita, che come tale deve essere in grado di garantire un’esistenza libera e dignitosa. Altrimenti, anche questo diritto diventa vulnerabile da ogni cosa nebulosa che si chiami, per esempio, «contingente situazione finanziaria». E il legislatore incorre in quella irragionevolezza che consiste nel privilegiare troppo un fine, o un interesse, o un bene, oltretutto in questo caso non costituzionalmente qualificato, a discapito di altri, che costituzionalmente qualificati invece sono.
Emergono mi pare da questa impostazione le risorse di una forma di razionalità, controversiale, abituata a considerare le questioni in contraddittorio, e cioè a ragionare in presenza di interessi e di punti di vista diversi e tenendone conto. Questo modo di ragionare concorre a una considerazione dei problemi della convivenza più ampia e più duttile di quella spesso solo calcolante cui altri ambiti di esperienza, come la politica o l’economia, spesso si riducono, finendo così, se lasciati soli, più facilmente per cadere in quel tipo di abusi che scaturiscono da una visione unilaterale, ossia da una considerazione troppo ristretta della complessità dei temi e della pluralità delle loro possibili letture. Si sente poi il beneficio che in ogni discussione sempre viene dall’esercizio di quel certo rigore di ragionamento (che è in sé una istanza etica), che impone di distinguere un problema da un altro. Alcuni hanno rimproverato la Corte di non avere adottato qui il precedente della sentenza sulla Robin Tax, in cui essa, con notevole innovazione, ha limitato gli effetti della propria decisione solo al futuro. Ma là, per menzionare solo una differenza, si trattava di materia tributaria e di libertà di iniziativa economica, dove ricorrono principi, precedenti e tradizioni normative ben diversi da quelli che vigono nel campo del diritto alla retribuzione, su cui invece incide il decreto sulle pensioni. Se facesse di ogni erba un fascio, un giudice non sarebbe un giudice.
Forse è proprio perché ci ricorda che si può non fare di ogni erba un fascio, che esistono forme di razionalità, punti di vista e modi di conoscere diversi, che la sentenza suscita lo scandalo che suscita. Per lo stesso motivo essa rappresenta, mi pare, un apporto importante affinché restino vigorosi il valore dell’indipendenza, del pluralismo e di una collaborazione leale, perciò paritetica e non servente, tra istituzioni, prassi, e saperi che hanno ruoli e funzioni sociali differenti.
Cosa sarebbe successo, infatti, se la Corte si fosse messa d’impegno per cavare essa stessa, dallo striminzito riferimento del decreto alla «contingente situazione finanziaria», argomenti per dimostrare che il governo aveva invece voluto tutelare le generazioni future, mantenere l’equilibrio di bilancio, i rapporti con la Ue, o anche revocare ingiusti privilegi e che perciò il decreto era conforme a Costituzione o la questione infondata? Il suo sarebbe stato un lavoro di fantasia, perché nessuna di queste cose il decreto menzionava e offriva al giudizio. Peggio, si sarebbe trattato di un annusare lo «spirito dei tempi» per farne norma generale: l’austerità prevale sui diritti, sempre e comunque. Né la Corte poteva fare un intervento «manipolativo», cioè dettare essa il modo corretto di bilanciare gli interessi in gioco, posto che il legislatore, rifugiandosi nel rinvio alla «contingente situazione finanziaria» non aveva indicato quali beni costituzionali intendesse garantire, o quali finalità perseguire, onde non vi era la possibilità di individuare i parametri intorno cui correggere e ricalibrare il suo intervento, a meno di esercitare, di nuovo, una supplenza ideativa in cui il ruolo di un giudice costituzionale si confonde con quello di un maggiordomo che cuce, a posteriori, pezze giustificative al legislatore inventandosi, all’occorrenza, valori di nuovo conio.
Non che non vi sia chi, anche in modi molto raffinati, pensa che proprio questo — politico dunque più che giurisdizionale — dovrebbe essere il ruolo della Corte e il suo modo di usare la ragione. Ma questa è l’occasione per osservare che se la Corte operasse in tal modo saremmo un paese senza diritto, qual è quello in cui il diritto coincide con le valutazioni di opportunità di chi governa, offrendo nulla più che la tecnica di scrivere e riscrivere. Disposti a cambiare oggi quello che era valido ieri, senz’altra ragione che ora come ora, assertivamente, conviene o è necessario far così. Richiamando il dovere di ragionevolezza che grava sul legislatore la Corte ha fatto appello all’essenza del suo ruolo, e del ruolo di ogni giudice, quello di garantire l’eguaglianza tra governanti e governati: non solo i secondi, ma anche i primi sono astratti da vincoli.
Si spera dunque che gli organi politici, cui, come ha precisato il presidente della Corte, quest’ultima ha restituito intatta la responsabilità decisionale, siano all’altezza dell’invito che la sentenza sulle pensioni ha loro rivolto. Lo metterò, questo invito, in parole mie, che non mi sembra si discostino troppo dal messaggio che promana dalla sentenza: una democrazia costituzionale si governa sforzandosi di ricercare e far valere ragioni capaci di sostenere un confronto e di annodare, nel mutamento, le esigenze di oggi con gli impegni di ieri. Nulla in effetti minaccia i diritti, delle generazioni presenti e di quelle future, più degli abusi del potere.


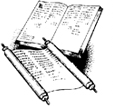

0 commenti
Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.
Lascia un commento