Francesco Cocco
Francamente mi lascia perplesso l’affermazione di Massimo D’Alema che la “classe politica” della “Prima Repubblica” era migliore di quella attuale perché era composta prevalentemente da politici di professione. A meno che “politico di professione” non debba essere inteso in un significato ben diverso da quello di “politico di mestiere”.
Certamente quella classe politica era migliore. Questo è un giudizio che condivido appieno. La superiorità non derivava dall’essere tali per mestiere piuttosto dal fatto che erano ancora in piedi i valori della Resistenza, che i rappresentanti nelle istituzioni erano espressione di una società non ancora atomizzata e degradata, che vigeva un forte sentimento di democrazia partecipativa, che la vita politica non era ancora corrotta da fenomeni di leaderismo deteriore, soprattutto dal fatto che i partiti assolvevano ad un effettivo ruolo di organizzazione politica della società e non si erano ridotti ad una dimensione di tipo aziendalistico con forme di obbedienza imprenditoriale. Questo per indicare alcuni elementi esemplificativi, senza esaurire i momenti di un processo molto complesso.
Diciamo che nella “Prima Repubblica” i canali di collegamento tra società civile e vita istituzionale erano garantiti dai partiti di massa. I quali, pur con mille limiti, assolvevano ad un ruolo di selezione dei rappresentati nelle istituzioni. Quei partiti erano certamente da riformare profondamente ma non da distruggere. Il “partito leggero”, di “occhettiana memoria”, è servito, nel suo esito finale, a favorire il “partito azienda”. Così, in forme diverse, sono risorti dopo un secolo i “capi bastone”, in forme diverse ma tali nella sostanza.
Negli anni Novanta del secolo scorso si è pensato che i problemi fossero risolvibili immettendo direttamente nelle istituzioni personalità (talvolta personaggi discutibili) della società civile. Fenomeno al quale abbiamo potuto assistere sino alle elezioni politiche della primavera scorsa. Prima vi è stato il turno dei magistrati, poi quello degli imprenditori che avrebbero dovuto “risollevare” le compromesse fortune istituzionali.
Si è dimenticato che il ruolo del magistrato è di “terzietà” rispetto ai problemi nei quali il politico deve calarsi, e che la logica dell’impresa è ben diversa da quella delle istituzioni rappresentative. Queste ultime hanno per loro natura una funzione di mediazione (nell’accezione nobile del termine non certo in quella di compromesso deteriore) per far sì che le molteplici componenti della società abbiano soddisfatte le loro esigenze, per quanto compatibili con quelle generali.
La logica imprenditoriale è per sua natura monocratica, incapace di recepire le esigenze di partecipazione che un’effettiva democrazia comporta. Naturalmente questo non significa che un magistrato o un imprenditore non possano o non debbano assolvere ad un ruolo di rappresentanza o di guida delle istituzioni. Semplicemente dovranno seguire ed applicare altre logiche rispetto a quelle proprie del loro mondo di provenienza.
Quel che appare necessario per migliorare la “classe politica” è ripristinare il ponte tra società civile e istituzioni. Prima l’esercizio di un ruolo istituzionale presupponeva un lungo apprendistato fatto innanzitutto di dedizione. L’apprendistato era impegno politico esercitato nella società civile. Qui nasceva e si formava la “professionalità politica”, che implicava impegno e fedeltà al mondo che si era chiamati a rappresentare. Professionalità non era separatezza rispetto alla società civile, ma un di più rispetto al lavoro esercitato. Anzi la serietà nel lavoro era la prima garanzia dell’impegno politico, e rendeva credibile quest’ultimo. Insomma, era l’homo civicus, che dedicava una parte del suo tempo, dopo il lavoro, con serietà e rigore, alla polis, ai concittadini.
Se la professionalità è intesa in questo senso il giudizio di D’Alema è condivisibile. Sarebbe molto discutibile pensare di rivitalizzare oggi la dimensione del “funzionariato di partito” com’era inteso nei partiti della sinistra sino a qualche decennio fa. Quella era una dimensione propria di una certa fase storica che oggi ha perduto del tutto la sua validità.


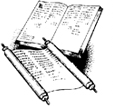

0 commenti
Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.
Lascia un commento