Gianfranco Sabattini
Perché la distribuzione della ricchezza, la crescita economica e lo sviluppo continuano ancora a caratterizzare una disuguaglianza globale tra gran parte dei Paesi del mondo? All’interrogativo tentano di dare una risposta Daron Acemoglu e James Robinson, il primo economista al MIT e il secondo scienziato politico di Harvard, in un loro ponderoso volume dal titolo: “Perché le nazioni falliscono”.
Secondo gli autori, si potrebbe pensare che la risposta possa essere data sulla base di una spiegazione condivisa dalla quasi generalità di coloro che si occupano delle disparità esistenti in fatto di distribuzione, a livello mondiale, delle povertà, della ricchezza e dei ritmi di crescita; invece, accade che così non sia e che la maggior parte delle risposte non siano soddisfacenti. Molte sono, infatti, le ipotesi cui si fa normalmente ricorso per formulare un’adeguata risposta all’interrogativo; di tali ipotesi, le principali sono quella geografica, quella culturale e quella dell’ignoranza, o dell’insufficiente acculturazione.
Secondo la prima ipotesi, il gap tra Paesi “ricchi” e Paesi “poveri” è riconducibile alla diversità della loro collocazione geografica; secondo l’ipotesi culturale, esso è imputabile alla diversità dei valori e delle credenze condivisi; infine, secondo l’ipotesi dell’ignoranza, il gap è causato dal fatto che le società civili dei Pesi “poveri” e le loro classi dirigenti non sappiano come utilizzare razionalmente le risorse delle quali dispongono. Tutte queste ipotesi, assieme a tutte le loro possibili varianti, non consentono di dare risposte adeguate al perché della disuguaglianza globale esistente; per comprenderne la ragione occorre “prima capire perché alcune società siano organizzate in modo inefficiente e socialmente fallimentare”. La tesi di Acemoglu e di Robinson è che la maggior parte degli economisti e degli studiosi di scienza della politica si sia concentrata su come risolvere i problemi, mentre per capire il fenomeno della disuguaglianza globale occorre, soprattutto, spiegare come all’interno dei Paesi “poveri” o all’interno dei Paesi in recessione strutturale, i problemi si creino. A tal fine, occorre andare oltre la teoria economica, e studiare anche i processi politici decisionali prevalenti, all’origine dei problemi stessi.
Secondo Acemoglu-Robinson, il superamento della povertà, ad esempio, dipende dalla soluzione di alcuni fondamentali problemi politici originari; proprio perché la teoria economica ha sempre mancato di considerare la dimensione politica dell’arretratezza, essa non è stata in grado di fornire una spiegazione convincente della disuguaglianza globale. Per rimuovere tale deficit conoscitivo, se l’economia è utile per comprendere come il diverso modo in cui i Paesi “poveri” sono organizzati condizioni il comportamento economico, la politica è chiamata a dare prioritariamente una risposta al problema dell’organizzazione propria di quei Paesi.
Sulla scorta dei loro assunti, Acemoglu e Robinson, affermano che la disuguaglianza globale è imputabile alla diversa natura delle istituzioni che regolano il modo in cui si svolge l’attività politica e il funzionamento dell’attività economica, da un lato, ed il comportamento degli attori politici ed economici, dall’altro. Tali istituzioni possono essere “inclusive” oppure “estrattive”: quelle inclusive plasmano la società in modo tale per cui le opportunità risultano equamente distribuite, mentre quelle estrattive consentono la “cattura” delle opportunità da parte di ristretti gruppi a proprio esclusivo vantaggio. Tra il primo tipo di istituzioni e le seconde esiste una relazione stretta, che può originare un circolo virtuoso, oppure un circolo vizioso. Quando le istituzioni politiche sono inclusive, aperte alla libera iniziativa e alla partecipazione al processo decisionale della generalità dei componenti il sistema sociale, esse originano a loro volta istituzioni economiche inclusive, impedendo che i loro attori pongano in essere comportamenti arbitrari; mentre, quando le istituzioni politiche sono di natura estrattiva concorrono a creare istituzioni economiche anch’esse estrattive, i cui attori agiscono senza regole, condizionando l’evoluzione futura del sistema politico-istituzionale e di quello economico.
I Paesi “poveri” non sono riusciti o mancano di riuscire a superare il loro stato di stagnazione, quando hanno istituzioni politiche ed economiche estrattive; l’acquisizione di istituzioni politiche, perciò, costituisce un momento importante ai fini della comprensione, non solo delle cause che hanno bloccato i Paesi “poveri” sulla via della crescita e dello sviluppo, ma anche del perché i Paesi “ricchi” possono fallire, allorché, a seguito di un processo degenerativo delle istituzioni politiche, essi acquisiscono delle istituzioni economiche estrattive, nella prospettiva che la degenerazione delle prime continuerà ad approfondirsi per effetto dei condizionamenti esercitati dalle seconde.
Secondo Acemoglu-Robinson, è importante comprendere come la storia e le congiunture critiche dei singoli contesti sociali diano forma alle istituzioni politiche inclusive; esse non nascono via fax spedito dal cielo, ma sono l’esito dei punti di svolta nei rapporti di forza esistenti tra i diversi gruppi che operano e interagiscono all’interno del sistema sociale, dotato di un minimo di organizzazione istituzionale; ogni congiuntura critica è però un’arma a doppio taglio, nel senso che può determinare cambiamenti di segno opposto nell’ evoluzione del sistema sociale. L’esito del “conflitto” tra i gruppi non è mai certo, in quanto dalla sua risoluzione può attivarsi un circolo virtuoso, oppure un circolo vizioso. Se emergono istituzioni politiche inclusive, seguirà la formazione di istituzioni economiche anch’esse inclusive; una volta emerse, sia le prime che le seconde “innescano…un processo di retroazione positiva grazie al quale esse aumentano la probabilità di persistere o addirittura di espandersi”.
Il circolo virtuoso è rinforzato da diversi meccanismi. Il primo è espresso dalla logica propria delle istituzioni pluraliste, quali sono appunto le istituzioni inclusive, considerato che il pluralismo racchiude in sé il concetto di Stato di diritto, che, a sua volta scoraggia l’uso “ad personam” delle istituzioni da parte di un gruppo ai danni di un altro; un secondo meccanismo consiste nel fatto che, una volta create, le istituzioni economiche inclusive supportano quelle politiche dalle quali esse hanno tratto origine; un terzo meccanismo, infine, è innescato dall’affermarsi, dopo la formazione delle istituzioni politiche inclusive, di mezzi di comunicazione indipendenti, in grado di mobilitare l’opinione pubblica nel caso in cui le istituzioni inclusive siano minacciate dai gruppi di opposizione.
Tuttavia, benché il circolo virtuoso, una volta attivato, sorregga vieppiù le istituzioni inclusive, le forze di opposizione conservano vive le propensioni di coloro che hanno interesse a ricuperare le istituzioni estrattive; ciò perché, come osservano Acemoglu e Robinson, la storia “non è libro già scritto”, e i circoli viziosi, per quanto non siano impossibili da arrestare, hanno una grande capacità di resistenza, potendo attivare contingentemente forze di retroazione negative. Quando ciò si verifica, se le forze negative non sono adeguatamente contrastate, possono dare il via a un processo di feedback negativi, con la conseguente resuscitazione di istituzioni politiche ed economiche estrattive, che riconducono il sistema sociale, in qualche modo fuoriuscito dalla sua originaria condizione di povertà, al suo status originario; o, nel caso di un sistema sociale già inserito nel novero dei Paesi “ricchi”, di interrompere la crescita e lo sviluppo, approfondendo le disuguaglianze distributive al suo interno.
La teoria di Acemoglu e di Robinson è veramente in grado di spiegare, in termini più esaustivi e compiuti di quelli tradizionalmente offerti dalla teoria economica, i principali aspetti dello sviluppo politico ed economico globale? Gli autori sono convinti d’essere riusciti nel loro intento, articolando la loro teoria su due livelli. Il primo attiene alla spiegazione di natura storico-politico-istituzionale dei motivi per cui le istituzioni inclusive sono emerse in alcune parti del mondo e non in altre; ma anche perché alcuni Paesi o regioni in ritardo sulla via della crescita e dello sviluppo stentano o non riescono a rompere lo status stagnante che li caratterizza e perché alcuni Paesi, dopo essersi inseriti nel novero dei Paesi “ricchi”, oggi tendono a fallire e a perdere il rango di Paesi sviluppati. Il secondo livello concerne il modo in cui la storia può orientare le “traiettorie” politico-istituzionali ed economiche dei Paesi, conservandoli, a seconda dei casi, nella prospettiva di un circolo virtuoso, oppure di un circolo vizioso.
La teoria di Acemoglu e di Robinson motiva il lettore a tentare di applicarla all’esperienza dell’Italia contemporanea, sia riguardo al fallimento delle politiche di sostegno della crescita e dello sviluppo delle regioni meridionali, sia al processo involutivo che il nostro Paese sta oggi sperimentando sul piano politico ed economico.
Riguardo al fallimento dell’intervento straordinario realizzato, ad esempio nell’ultima metà del secolo scorso in pro delle regioni meridionali, occorre riconoscere la plausibilità delle argomentazioni di chi sostiene che l’insuccesso delle politiche meridionalistiche sia imputabile al fatto che esse sono state attuate in presenza di istituzioni regionali di natura estrattiva e che il resto del Paese, che trasferiva le risorse per finanziare la nascita di istituzioni economiche inclusive, ha trascurato la necessità che l’intervento fosse diretto prioritariamente a modificare la natura delle istituzioni politiche locali.
Il fatto che tali istituzioni non siano state modificate fonda perciò l’ipotesi che la causa sia da imputarsi alla circostanza che le risorse trasferite siano state catturate e utilizzate a proprio vantaggio da ristretti gruppi sociali e non a vantaggio delle intere società civili delle regioni meridionali; ciò non è che una riprova, più in generale, del perché gli aiuti internazionali in favore dei Paesi “poveri” hanno mancato di promuovere un processo di crescita e sviluppo, in quanto gli aiuti sono stati “fagocitati” da gruppi ristretti, a causa della mancanza in quei Paesi di istituzioni politiche inclusive.
Riguardo alla fase contingente che l’Italia sta oggi attraversando, la teoria di Acemoglu e Robinson conferma l’ipotesi che il processo involutivo nel quale il Paese è attualmente inserito sia imputabile alla degenerazione delle sue istituzioni politiche ed economiche; il ricupero della loro interazione all’interno di un nuovo circolo virtuoso, se mai sarà possibile realizzarlo, deve avvenire in tempi brevi, pena i possibili esiti negativi di un futuro instabile ed incerto, ai danni di tutti.


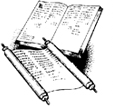

0 commenti
Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.
Lascia un commento