Gianfranco Sabattini
L’austerità alla quale sono stati sottoposti molti paesi dell’eurozona dopo la crisi scoppiata nel 2007/2008, autorevoli economisti, come Paul Krigman e Joseph Stiglitz (tanto per citarne due al di sopra di ogni sospetto), sostengono che essa è stata controproducente, in quanto ha provocato effetti recessivi e farà crescere il debito pubblico in rapporto al PIL.
Questa tesi è sostenuta in modo particolare da Krugman che, sulla scorta delle rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha stimato l’esistenza di una correlazione negativa tra le misure di austerità messe in atto dai paesi dell’area euro nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012 e il tasso di crescita contemporaneamente verificatosi. La correlazione ha presentato alti valori, per cui la conclusione che Krugman ne ha tratto è che l’austerità non è stata la misura migliore per porre rimedio alla crisi, o per “tamponare” e ridurre il debito sovrano.
Questa conclusione ha indotto Lorenzo Bini Smaghi, ex membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE), a porre, in un suo scritto, apparso in “La voce.info” col titolo “L’austerità non è solo figlia delle stupidità”, a porre la fatidica domanda: se le cose stanno come afferma Krugman, perché i politici dei paesi dell’eurozona in crisi hanno continuato e continuano ad adottare misure di austerità? Krugman risponde sbrigativamente che ciò è accaduto e continua ad accadere perché i “politici non sono particolarmente intelligenti”, o perché sono mal consigliati, per cui in definitiva si dimostrano ”ignoranti in fatto di economia”.
Per Bini Smaghi esiste un modo alternativo, meno tranchant, per rispondere all’interrogativo; a tal fine, occorre interrogarsi più responsabilmente sulla causalità intrinseca alla correlazione tra austerità e crescita. Riflettendo sulla cause che influenzano tale correlazione, egli risponde che i politici europei non sono stupidi per aver perseguito l’austerità, in quanto non hanno avuto altra scelta a disposizione.
A sostegno delle sua diversa risposta, rispetto a Krugman, all’interrogativo sopra formulato, Bini Smaghi utilizza la stessa metodologia del premio Nobel americano ed osserva che l’analisi fondata su “un campione di sole undici osservazioni”, dovrebbe essere utilizzata e letta con maggiore cautela, in quanto è assai probabile che i risultati cui essa ha condotto siano stati distorti dalla presenza di casi particolari, quale è stato, ad esempio, quello della Grecia; a questo paese “una dose altissima di austerità è stata imposta” dal fatto che l’economia greca era caratterizzata da forti rigidità e insufficienze.
Infatti, se si esclude la Grecia dal novero dei paesi dell’eurozona, afferma Bini Smaghi, i valori della correlazione negativa tra austerità e crescita scendono in modo drastico. Per l’ex membro del comitato esecutivo della BCE, ciò significa che i tassi di crescita sono stati influenzati, non solo dall’austerità, ma anche da altri fattori, che valgono a spiegare i differenziali di crescita riferiti all’insieme dei paesi dell’eurozona e quindi a chiarire il perché del prevalente ricorso all’austerità.
Un primo fattore è da individuarsi nelle condizioni di finanziamento dell’economia nel suo insieme, nel senso che i paesi, come l’Italia, con i più alti costi del credito hanno sperimentato una più bassa crescita; ciò perché tali paesi, oltre che afflitti da alte rigidità nelle condizioni di finanziamento, hanno anche subito gli effetti di bassi tassi di crescita che hanno giustificato il ricorso, quasi obbligatoriamente, a misure di austerità. Queste considerazioni possono essere estese anche alla correlazione tra rischio sovrano e rischio bancario, nel senso che l’inasprimento delle condizioni di credito nei paesi più indebitati spiega perché tali condizioni siano state un importante fattore che ha compresso l’andamento dei tassi di crescita.
Un secondo fattore è da rinvenirsi negli squilibri strutturali accumulatisi nei primi anni di unione monetaria; questi squilibri hanno influenzato negativamente, sia i potenziali di crescita, che la competitività del sistema-paese, per cui anche la loro presenza, originando una perdita di competitività dell’intera base produttiva e, conseguentemente, bassi ritmi di crescita, ha giustificato per i paesi in crisi il prevalente ricorso all’austerità.
Un terzo fattore è da identificarsi nel fatto che i paesi caratterizzatisi durante la crisi per una bassa crescita potenziale, a causa degli squilibri strutturali, sono anche quelli che all’inizio della fuoriuscita dalla crisi presentano la minor propensione a crescere.
Quale la conseguenza del ricorrere dei tre fattori illustrati? A giudizio di Bini Smaghi, non è l’austerità che “ha causato la bassa crescita, è la bassa crescita che ha causato l’austerità. In altri termini, i paesi che hanno sperimentato una bassa crescita potenziale, a causa di profondi problemi strutturali…hanno accumulato, prima, un eccesso di debito pubblico e privato, che poi, quando la crisi è scoppiata, si è rivelato insostenibile e ha richiesto un brusco aggiustamento”; cioè ha imposto solo misure di austerità. Questa ha certamente originato bassi tassi di crescita, ma essa è stata l’esito di una “crescita scarsa e squilibrata, a causa della mancanza di riforme strutturali”. La mancata attuazione delle riforme che migliorassero il potenziale di crescita ha lasciato un’unica possibilità ai paesi afflitti dagli effetti dei fattori prima indicati: il ricorso all’austerità. Quest’ultima è divenuta così una scelta obbligata dei politici, ma non tanto per la loro stupidità, quanto per la mancanza di alternative; soprattutto per la carenza di risorse con cui finanziare le riforme senza eccessivi sacrifici sul piano dello Stato sociale.
Stando così le cose, vien fatto di osservare che l’uscita dal basso potenziale di crescita non passa attraverso l’”uscita dall’austerità”, ma dal reperimento delle risorse con cui finanziare l’attuazione delle riforme strutturali; ciò significa che l’accusa di stupidità rivolta dagli economisti ai politici perché obbligati, loro malgrado, ad una scelta poco compatibile con la crescita, può essere facilmente ribaltata; senza l’indicazione delle procedure da attuarsi a tutti livelli per acquisire le risorse necessarie a finanziare la rimozione degli squilibri strutturali, anche gli economisti si espongono all’accusa di stupidità da parte dei politici.
La stupidità, pertanto, non va tanto correlata alla propensione ad attuare politiche di austerità a causa del basso potenziale di crescita, quanto alla disponibilità di tutti, politici ed economisti, a tentare di sottrarre i paesi dell’eurozona in crisi dai vincoli della “camicia di forza” in cui si sono trasformate le rigide regole monetarie dell’Unione Europea.


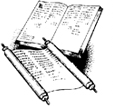

0 commenti
Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.
Lascia un commento