Andrea Pubusa
Luciano Canfora ha colpito ancora, ha scritto un altro bel volumetto, da non perdere: Libro e libertà, prezzo € 6,00, Editore Laterza (collana Economica Laterza). Ci parla - come si legge nella presentazione - di censura, roghi, libri immaginari, bibliomania e criminalità per e contro i libri: il potere del libro e la lotta tra libro e potere in un testo appassionato e sorprendente. Dalla lettura come passione morbosa alla biblioteca come specchio di chi la possiede o la inventa, dal ‘furor d’aver libri’ alla ‘dotta ignoranza’ del bibliotecario di professione.
Questo suo parlare di libri e bibioteche, quelle storiche e quelle di grandi intellettuali del passato o anche solo di grandi ricchi, mi ha riportato alla mente la prima volta che ho visto una biblioteca “privata”. Tanto fu lo stupore che mi è rimasto impresso fino ad oggi il giorno in cui, da bambino, a Carbonia, vidi a casa di un mio amichetto di scuola, Giancarlo Perra, la biblioteca dei genitori, operaio il padre e casalinga la madre. Avevano uno scaffaletto di tre-quattro piani con tanti piccoli libri allineati e ben ordinati, forse edizioni Rinascita, Ed. in lingue estere, Cultura sociale e Colip - Coop. del libro popolare, e forse altre ancora. C’erano autori importanti da Marx a Lenin a Gramsci, a Togliatti, e anche le loro grandi fotografie. Era una biblioteca, certo non sontuosa come quelle di cui ci parla Canfora nel suo libro, ma per me fu una sorpresa: a casa mia c’erano solo i libri scolastici, con due sole eccezioni: il vangelo, donatomi dalla maestra Pintaddu, e un volumone de I Miserabili portato da chissà chi. Quella piccola biblioteca a casa del mio amico, nell’Albergo operaio di via Mazzini, non lontano dalla grande miniera di Serbariu, mi sembrava fuor di luogo, una stravaganza. Ma per i suoi proprietari, un operaio comunista e la moglie, era evidentemente utile. E ricordo ancora lo stupore quando un giorno finì, sempre con Giancarlo, nella sezione del Partito comunista del nostro quartiere. Lì trovammo i genitori e tanti altri lavoratori e lavoratrici, che commentavano un libro, che un giovane con gli occhiali illustrava loro. Destò in me meraviglia che quelle persone, ormai adulte, per di più minatori o casalinghe, semianalfabeti, avessero libri e studiassero. Mi sembrava strano che nella sezione comunista, di cui all’oratorio il prete ci parlava un gran male, si leggessero e si scambiassero libri. A che pro libri e lettura collettiva? L’ho capito solo un po’ più avanti.
Ecco perché mi ha affascinato il racconto di Canfora e mi ha quasi commosso il finale, intitolato “Liber” perché riassume la vicenda umana di molti di noi.. Eccolo in sintesi. Ci sono romanzi nella cui vicenda la biblioteca è un luogo determinante. Essa è ad esempio la fonte della follia di Don Chisciotte. Dopo nottate passate a leggere “da un crepuscolo all’altro” e le giornate “dalla prima all’ultima luce”, gli parve “conveniente e necessario” farsi cavaliere errante, al fine di cimentarsi “in tutto ciò che aveva letto che i cavalieri erranti si cimentavanom disfacendo ogni speciie di torti”. Invece il saggio antico, ma anche l’umanista suo emulo, legge per rinsaldarsi nella sua saggezza. Non per agire. Perciò Don Chisciotte è pazzo. In questo, osserva Canfora, “si può forse ravvisare un poetico antecedente della tesi, aforisticamente espressa due secoli dopo, secondo cui “sino ad ora i filosofi si sono linitati a interpretare il mondo, ora l’importante è cambiarlo”. Entrambi debbono molto ad un motto ripetuto spesso, anche da chi poco lo intende: “la verità ci farà liberi”. Dove l’accento è su fare.
Con amarezza temperata dall’ironia, Cervantes scrive nel Prologo di aver generato “nel fondo di un carcere” questo figlio “secco, ossuto e fantastico”. Non era una metafora: fu carcere vero. Nel carcere fascista, Antonio Gramsci scrisse alcune delle pagine più durevoli della nostra prosa novecentesca, Le lettere dal carcere, e schizzò il profilo e meditò la sostanza di alcuni libri, complessivamente indicati come Quaderni del carcere, che hanno sospinto poi l’agire per la libertà intere generazioni. E’ antico e molteplice il nessi tra libro e libertà”.
Questa la bella conclusione di Canfora. Ed è proprio così come lui dice. Nell’animo di ogni «pazzo di libri» c’è un Don Chisciotte – che, a furia di leggere, entra nel mondo dei suoi libri, ragiona come se fosse egli stesso un soggetto di quei libri e addirittura vive con quei personaggi. Diviene così protagonista della sua liberazione, come quei genitori, lavoratori comunisti, del mio amichetto Giancarlo e i loro compagni, a Carbonia, negli anni ‘50. Anche a me bambino, quella piccola biblioteca nella loro abitazione all’Albergo operaio di via Mazzini, sembrò folle e ancor più pazzi e ridicoli mi parvero quei lavoratori e lavoratrici, semianalfabeti, che nella sezione comunista, leggevano insieme un libro e discutevano, stimolati da un giovane con gli occhiali, folle più di loro, che pretendeva di elevare questi lavoratori che, a mala pena, sapevano scrivere il loro nome. Il libro e la lettura perché? Poi ho capito, che leggevano nientemeno che per cambiare il mondo, per spezzare le catene dello sfruttamento, per migliorare la loro condizione. E quando l’ho capito, mi sono unito a loro, imparando da loro le cose migliori.


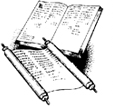

1 commento
1 Pasquale Mascia
13 Marzo 2014 - 17:07
Che piacere leggere di biblioteche e di passione per la lettura facendo riferimento ad un libro intelligente e non al vorticoso mondo del marketing culturale che scambia quell’ “ansia di cambiare il mondo con la lettura” con un bisogno da supermercato! Quando si tornerà a parlare del diritto alla biblioteca? Grazie professore!
Lascia un commento